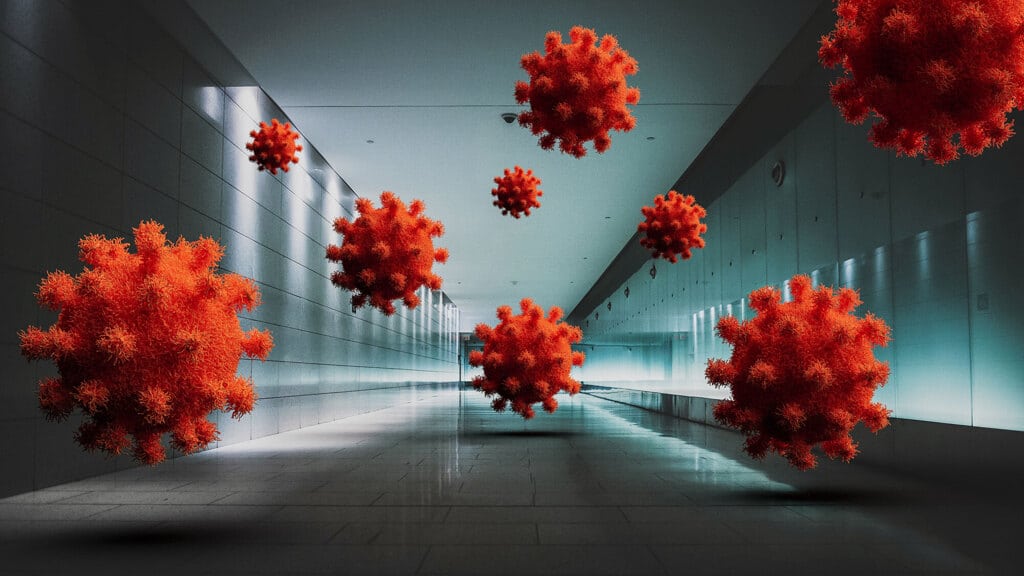Da qualche parte là fuori c’è una terra promessa chiamata Normalità, dove un giorno potremo far ritorno. Almeno questa è la geografia magica che ci propinano i politici ed è la storia che ci raccontiamo, anche solo per poi contraddirla. Ci sono motivi concreti per ritenere che la normalità sia un mondo delle favole a cui non potremo mai tornare. Il virus non è sparito, ed è probabile che torni a ondate. Ma la vera domanda è: se un mondo simile esistesse, vorremmo davvero viverci?
Stando a diversi sondaggi la risposta è no. In base a quello fatto dalla società di consulenza BritainThinks a luglio, solo il 12 per cento degli intervistati vuole che la vita sia “tale e quale a prima”. Secondo quello commissionato alla fine di giugno dall’organizzazione per l’assistenza all’infanzia Bright horizons, solo al 13 per cento piacerebbe lavorare come prima del lockdown. E uno studio della società di ricerche di mercato YouGov condotto nello stesso periodo ha rivelato che appena il 6 per cento dei britannici vuole lo stesso tipo di economia precedente al covid-19.
Immaginazione morale
Ovviamente vorremmo tutti lasciarci alle spalle la pandemia con i suoi effetti devastanti sulla salute fisica e mentale, l’esasperazione della solitudine, la chiusura delle scuole e il crollo dell’occupazione. Il che, però, non equivale a desiderare il ritorno al mondo spaventoso che il governo definisce normale. Oltre alle storture politiche ed economiche, normalità significa aggravare la crisi più assurda e profonda con cui l’umanità si sia mai misurata: il crollo dei sistemi ecologici che ne garantiscono la sopravvivenza.
Mentre eravamo chiusi in casa, abbiamo visto il fumo levarsi dall’Artico, dove temperature anomale hanno toccato i 38 gradi. Scorriamo le immagini apocalittiche del fuoco che consuma l’Australia, la California o il Brasile, e senza volerlo le normalizziamo. In un articolo uscito sul Guardian all’inizio dell’anno, Mark O’Connell lo definisce “il lento atrofizzarsi dell’immaginazione morale”. Ci stiamo adattando alla nostra crisi esistenziale.
Con il ritorno alla normalità riprenderà anche l’inquinamento atmosferico, che ogni anno uccide più di quanto abbia fatto finora il covid-19. L’emergenza climatica e l’inquinamento sono due aspetti di una più vasta disbiosi. Questo termine medico è usato di solito per indicare un’alterazione della flora intestinale, ma si può applicare a tutti i sistemi viventi – foreste pluviali, barriere coralline, fiumi, suolo – in rapido sfacelo a causa degli effetti cumulativi della normalità, che consiste nella crescita perpetua dei consumi.
A luglio abbiamo appreso che ogni anno metalli preziosi come l’oro e il platino, per un valore pari a dieci miliardi di dollari, finiscono nelle discariche sotto forma di rifiuti elettronici, la cui produzione mondiale aumenta del 4 per cento all’anno, alimentata dall’obsolescenza programmata. Gli elettrodomestici sono progettati per guastarsi e non essere riparabili. Ecco perché di solito uno smartphone, che contiene materiali preziosi estratti a caro prezzo per l’ambiente, dura due o tre anni.
I complessi effetti a cascata della disbiosi ci spingono verso quello che secondo alcuni scienziati potrebbe essere un crollo sistemico globale. Anche qui i sondaggi parlano chiaro: non vogliamo tornare a quella follia. Un’indagine di YouGov indica che otto persone su dieci preferiscono che durante la pandemia il governo anteponga la salute alla crescita economica e sei su dieci lo vorrebbero anche quando (se) il virus dovesse placarsi. Un sondaggio di Ipsos ha un risultato simile: il 58 per cento dei britannici chiede una ripresa basata sull’economia verde, il 31 per cento no. Come in tutte le indagini di questo tipo, il Regno Unito è in fondo alla classifica: per lo stesso sondaggio, in Cina il rapporto è 80 a 16, in India 81 a 13.
Più si consuma, più l’immaginazione morale si atrofizza. Proprio come non esiste una persona normale, non esiste un’epoca normale. La normalità è un concetto usato per limitare l’immaginazione morale. Non c’è una normalità a cui poter tornare o da desiderare. Viviamo in un’epoca anomala che esige risposte anomale. ◆ sdf
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1372 di Internazionale, a pagina 82. Compra questo numero | Abbonati