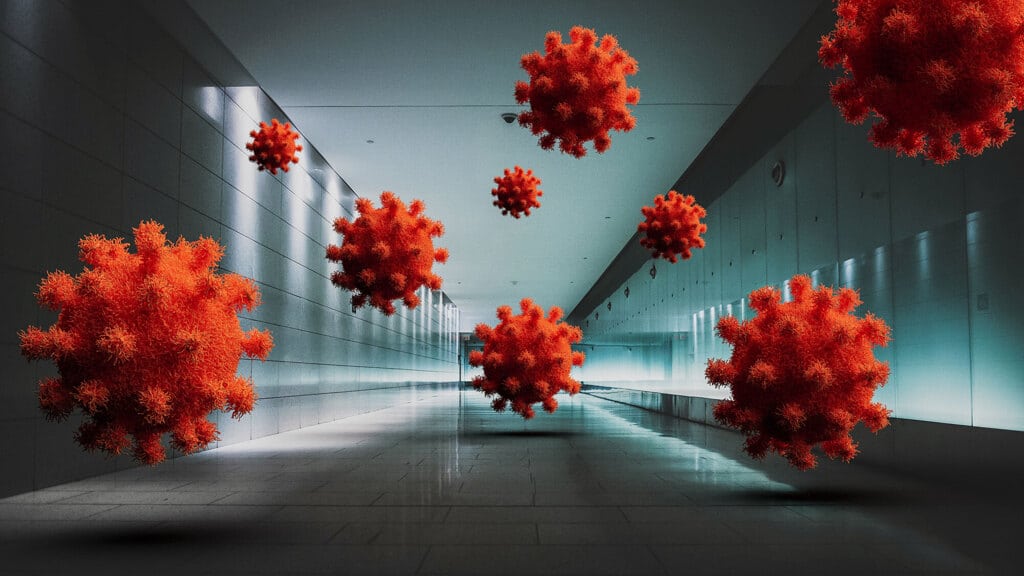Cent’anni fa nella città armena di Alessandropoli (oggi Gyumri) fu firmato il trattato di pace tra il governo kemalista turco ed Erevan, che rinunciava così al sogno della “grande Armenia” e perdeva le province di Kars e dell’Ararat. I confini sanciti dal trattato – firmato da un governo armeno non più in carica, perché obbligato a dimettersi dagli invasori sovietici il giorno prima – sono ancora in vigore.
Dopo l’accordo siglato il 9 novembre per mettere fine ai combattimenti in Nagorno Karabakh non si può parlare di perdite territoriali dirette per gli armeni, ma le conseguenze possono essere paragonabili. Dopo aver perso il suo “cuscinetto di sicurezza” con l’Armenia, e con l’esercito azero nella città di Shusha, il Nagorno Karabakh ha perso qualsiasi prospettiva di normale sviluppo. Ormai è solo questione di sopravvivenza.
Il vero vincitore è il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev. E il miglior amico dell’Azerbaigian è il leader turco Recep Tayyip Erdoğan, che ha sostenuto l’azione militare di Baku. La Turchia ha ottenuto il massimo possibile: in una fase di grandi difficoltà economiche, è un risultato molto importante per Erdoğan. Ora probabilmente Ankara costruirà nuovi rapporti anche con la Georgia, accrescendo la sua presenza nel Caucaso meridionale.
Nikol Pashinian, il premier armeno, farà invece da capro espiatorio. Dopo l’accordo è stato accusato di tradimento e la sede del governo è stata presa d’assalto da una folla inferocita. In prima fila tra i suoi accusatori ci sono quelli che nel 1998 fecero dimettere il presidente Levon Ter-Petrosian perché era pronto ad accettare un compromesso vantaggioso sul Karabakh, che avrebbe dato al paese vent’anni per prepararsi alla guerra appena combattuta. Ma tutto questo evidentemente non conta: la responsabilità dev’essere di Pashinian, in carica da due anni e mezzo.
La Russia, dal canto suo, si erge a garante degli armeni in Karabakh, mantenendo l’alleanza con Erevan. Ma lo fa senza entusiasmo, per necessità.
Mosca ha fatto la scelta giusta? Aveva alternative? I russi non vogliono fare la guerra, vogliono che siano risolti i problemi interni e di ordine economico. Non ci sono idee forti per mobilitare le persone. L’effetto galvanizzante della riconquista della Crimea, nel 2014, è passato e comunque la stessa dinamica non avrebbe funzionato in Karabakh, i cui abitanti non sono considerati compatrioti dai russi. Un’azione militare diretta era impossibile, e l’invio di volontari, cioè mercenari, non c’è stato per un motivo evidente: contro un esercito dotato di droni armati, come quello azero, sarebbero stati impotenti. La Russia, quindi, aveva una sola scelta: farsi garante della pace, assicurando la sua presenza sul terreno. Perché non è escluso che tra cinque anni l’Azerbaigian possa decidere di riaprire le ostilità. Baku ha aspettato molto, può aspettare ancora. Intanto può dedicarsi alla ricostruzione delle aree riconquistate e consolidare la sua presenza nella zona di Shusha. ◆ ab
◆ Dopo sei settimane di combattimenti, il 9 novembre 2020 Armenia e Azerbaigian hanno firmato un accordo che mette fine alla guerra nella regione contesa del Nagorno Karabakh e sancisce di fatto la vittoria militare azera. La tregua è stata raggiunta grazie alle mediazione del presidente russo Vladimir Putin, che invierà nella regione duemila soldati per assicurare il rispetto degli accordi. In base all’intesa, l’Azerbaigian prenderà il controllo di alcuni territori all’interno della repubblica filoarmena del Nagorno Karabakh e di buona parte delle aree che la circondano e che erano occupate dall’Armenia dal conflitto del 1994.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1384 di Internazionale, a pagina 26. Compra questo numero | Abbonati